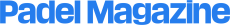Gustavo Spector, Mister Padel
Ha cominciato a giocare a padel a 20 anni e nel 2001 si è trasferito in Italia. Era B2 a tennis ma poi la suggestione di insegnare con la pala ha prevalso. Ora è capitano della Nazionale azzurra e il personaggio più celebre del padel in Italia
Dopo mezz’ora di intervista Gustavo Spector, il patriarca del padel italiano e stimatissimo tecnico della nazionale, scalpita: «Ricordati che adesso dobbiamo andare a fare lezione». E lo dice non a Fernando Belasteguín ma a uno che non è mai entrato in campo, perché vuole fargli scoprire come si prende la malattia di questo sport: giocandoci. Gustavo è nato nel 1969 «nella parte calda dell’Argentina», a Tucumán. A sei anni ha iniziato a giocare a tennis e, fino ai 15, quello è rimasto il suo unico amore. Nella provincia era regolarmente tra i primi classificati e per sua fortuna, a differenza dell’Italia, anche il liceo classico era votato allo sport, sicché formarsi una cultura umanistica e dedicarsi alla disciplina del cuore non era così complicato come da noi. «Anzi: tutti i primi sabati del mese, la scuola era impegnata nel weekend sportivo, non si faceva lezione ma gare su un campo polisportivo adatto per pallavolo, calcetto e basket». Gustavo era dotato: fisico atletico e compatto, mente pensante, a tennis sapeva fare tutto, giocare da fondocampo e attaccare.
Tucumán è la città di un altro sport, che da quelle parti si chiama touch rugby. E “Gus” era particolarmente attratto da un aspetto di quegli sport che al suo mancava: «Giocavo a tennis, mi piaceva, ero anche piuttosto bravo, valevo un seconda categoria. Ma ero affascinato dagli sport di squadra perché mi piaceva il fatto che, se fai parte di un team, quando sei nei guai gli altri ti aiutano. Nel tennis, invece, no: è uno sport che ti tiene in qualche modo in contatto con i tuoi coetanei e amici, perché giri per gli stessi tornei e quindi non è che soffri la solitudine ma, quando sei in difficoltà, ti ritrovi da solo. Anzi: il tuo migliore amico, in partita, diventa il nemico perché lo devi battere. Questa cosa la vivevo con grande sofferenza. Certo, mi sarei potuto rifugiare nel doppio, ma l’Argentina non è mai stata una patria di doppisti».
Il cammino di Gustavo Spector verso il padel cominciò così, col pensiero di uno sport di racchetta e non individuale, ma soprattutto con un gesto apparentemente lontanissimo dallo sport: l’iscrizione all’università. «Finii il primo anno di Legge, mi piaceva studiare il diritto perché è un insieme di regole che derivano da diversi punti di vista. Come il padel: a uno stesso problema, puoi dare risposte e soluzioni diverse. Per studiare, però, dovevo lasciare il tennis perché mi portava via troppo tempo. Era il 1989 e, dove vivevo io, c’erano solo due circoli che avevano i campi, nella parte più ricca della città. Fui portato lì da un amico del liceo che, sapendo del mio buon livello a tennis, pensava che gli sarei stato utile nel padel. Aveva ragione: nel primo torneo facemmo semifinale, nel secondo finale, il terzo lo vincemmo. Ero bravo: mi piaceva il discorso delle pareti, essendo un tennista tattico mi sono subito adattato. Ricordo che mi resi conto subito di quanto quello sport fosse vicino al mio modo di essere: ero felicissimo per una vittoria della nostra squadra anche quando avevo giocato da schifo. Una sensazione che nel tennis non vivevo quasi mai. Ho iniziato a provare piacere quando il mio compagno faceva punto, o quando il mio team vinceva, indipendentemente dalla mia prestazione».
La vita, però, stava per dare una bella sterzata ai piani della famiglia Spector: il circolo gli chiese subito di insegnare padel, perché c’era molta domanda e poca offerta di formazione specifica. Il prezzo da pagare era ponderoso: mollare gli studi. I genitori di Gus, felice che avesse lasciato il tennis per diventare avvocato, la presero male: «Li capivo, loro volevano che mi laureassi. In Argentina, peraltro, non ricordo di aver visto maestri di tennis anziani, perché è un lavoro che si fa da giovani, per guadagnare due lire studiando, per poi smettere e andare a cercarsi un mestiere “vero”. Purtroppo per i miei genitori, le cose con il padel andavano bene, fin troppo bene: diventai professionista dopo due anni. Al terzo torneo giocato, ritrovai il mio compagno di allenamenti di tennis. Giocavamo contro ma, da quella volta in poi, iniziammo a fare squadra. Per sette anni fummo inseparabili». E fecero razzia di trofei.
Andava davvero tutto bene: gli sponsor gli riconoscevano il corrispettivo di 2.500 euro al mese (e si parla degli anni Novanta), in più c’erano i premi per i tornei e le lezioni private. In poco tempo, Gustavo si era comprato casa e si era trovato un posto fisso nei primi 15 giocatori del suo Paese. «Solo che, nella mia città, c’era un broker assicurativo, e si dà il caso fosse di mio nonno. Verso i 26 anni, la mia famiglia mi prese da parte e mi disse: “Gus, fino a quando pensi di continuare a fare questa cosa? Quando ti troverai un lavoro?” E io mi feci convincere. Dopo il mondiale in Spagna del 1996, decisi di smettere col padel. Mi misi giacca e cravatta e andai a lavorare nell’azienda di famiglia. Guadagnavo bene, seguivo il ramo vita e investimenti e spesso c’era da andare negli Stati Uniti o in altri posti interessanti, ma ero tristissimo. A padel non giocavo più, perché mi faceva star male praticare come un hobby una cosa che avevo fatto così bene e con tanto impegno. Al massimo, ogni tanto giochicchiavo a tennis, tanto per rimanere attivo».
Finché il tappo non saltò, e arrivò la ribellione. Complice una questione storica che lega la terra di Spector alla nostra patria, terra di forte migrazione verso il Sudamerica nei primi anni del Novecento (tanto che alcuni celebri campioni di tennis come Guillermo Coria, David Nalbandian e Fernando Gonzalez hanno parenti italiani): «Ebbi il coraggio di rivoltarmi contro quella vita che non mi piaceva, e l’Italia era il posto giusto per farlo perché era una specie di Mecca, per noi. Nel nostro immaginario popolare l’Italia era perfetta, c’erano moltissimi migranti italiani stabiliti in Argentina i cui figli avevano il doppio passaporto e venivano chiamati dalle federazioni italiane per giocare qui, a suon di quattrini. Capii di potermi dare un’opportunità. Mi presi due mesi di tempo: prima stetti a Maiorca, a Barcellona, a Bilbao per vedere com’era la situazione, perché avevo alcuni contatti lì. Ma io volevo l’Italia e, nel 2001, mi trasferii a Milano. Un’amica di mia sorella mi presentò Alberto Pozzi, un maestro di Agrate Brianza che gestiva altri circoli nella zona. Feci un anno e mezzo dai lui, poi mi presentarono l’acquirente di un circolo di tennis di Peschiera Borromeo, che era stato di una banca. C’era tutto da fare, perché i soci erano solo i lavoratori della Comit. C’erano appena 110 tesserati e io riuscii a mettere su sette squadre: ero fissato, con l’idea della comunità e del team, per compensare la solitudine del tennista».
In quegli anni, dalle nostre parti si parlava poco o nulla, di padel. C’era qualche campo a Bologna e poco più, in tutto il territorio nazionale. La telefonata che sbloccò le cose arrivò a metà degli anni Duemila, quando il presidente della federazione lo chiamò offrendogli di allenare la nazionale italiana; intanto, nella sua Milano, nel 2007 vennero costruiti i primi campi, in via Pinerolo, e Gus riprese confidenza con il suo secondo amore. «Mi tornò la febbre del padel, tanto che proposi al mio circolo di mettere su dei campi da affiancare al tennis. Ma la proprietà non era convinta quanto me. Nel 2012, però, capitò una cosa strana: durante una fiera mi chiamarono per dirmi che una ditta aveva messo in vendita un campo da padel autoportante. Tornai alla carica col presidente, che però non era entusiasta: alla fine ci accordammo che me ne sarei occupato io e poi avremmo diviso gli incassi al 50%. Il giorno dopo ero già lì con gli attrezzi, stavo montando il campo. Poco tempo dopo, riuscii a prendere la gestione di uno spazio polifunzionale e comprai altri due campi. La gente cominciava ad appassionarsi ed erano sempre prenotati dal mattino alla sera».
Nel frattempo, il virus del padel si stava espandendo anche lungo la penisola. A Roma, Aniene, Parioli e altri circoli storici iniziavano a dare spazio a quel parente del tennis a lungo guardato con diffidenza, e non potevano fare altrimenti perché la gente lo provava e ne rimaneva entusiasta. Nel 2014, poi, la ex federazione italiana padel finì sotto l’egida della Fit. «Mi chiesero di iniziare a fare formazione. Avevo a disposizione solo mezza giornata, tra teoria e pratica, e su 15 regioni in cui andavo a fare i corsi ce n’erano 12 che non avevano neanche i campi! Il primo anno lo feci pure gratis, poi iniziarono a darmi qualcosina. Ma per me era una missione, non era una questione di soldi: volevo che la pratica del padel prendesse piede in tutto il Paese. Mi inventai delle slide con i video della palla al vetro, perché chi veniva ai corsi non solo non aveva mai giocato, ma spesso non aveva neanche mai visto un campo! Dovevo presentare una disciplina totalmente sconosciuta e appassionare gli istruttori al mio sport. Per gli esami, spesso, disegnavo i campi nelle palestre e usavo come riferimenti in altezza i lampadari… Ora, finalmente e dopo tante insistenze, il corso è diventato come lo volevo io: ci sono tre giorni di lezione per ottenere il diploma di primo livello, quattro giorni per il secondo livello, sei giorni per diventare maestro. Abbiamo molto materiale e la parte di formazione è diventata valida. Secondo me è fondamentale insegnare bene, perché un bravo maestro fa appassionare e aumenta la platea dei praticanti».

Ma con il suo entusiasmo, che si percepisce immediatamente come genuino, c’è da pensare che Spector sia la persona giusta per trascinare sempre più persone nella famiglia del padel. Senza riserve sul futuro di questo sport in Italia: «Quando mi chiedono se il padel è una moda come lo squash, rispondo sempre: hai mai giocato a squash? Io sì, l’ho provato. Me la cavavo anche bene. Ma è uno sport massacrante, non è per tutti, devi essere molto coordinato. A squash, vedi lezioni di principianti in cui il maestro tira venti palle e l’allievo non ne prende manco una. Invece il padel è davvero per tutti: prendi una racchetta in mano, vai in campo e ti diverti subito, adesso: non tra uno o tre mesi… A tennis, quando arrivava un allievo nuovo, il mio primo pensiero era quello di trattenerlo finché non avesse iniziato a divertirsi. Non c’è un motivo per non giocare a padel: si può divertire un ottimo tennista contro uno che con la racchetta non ha mai fatto niente. C’è gente in Argentina o in Spagna che pesa 120 chili ed è pure forte! E poi: in quale altro sport vedi giocare uomini e donne? Ci sono casalinghe che giocano tutti i giorni e finiscono per battere i loro mariti. Infine, c’è la parte sociale, che in tanti circoli di tennis ormai manca: dove sono io adesso, invece, la gente si trattiene a guardare le partite e gli allenamenti, si conosce, tanto che abbiamo dovuto mettere un piccolo bar perché in tanti si fermano qui prima e dopo aver giocato». Per far funzionare tutto, ovvero il centro a City Life a Milano e gli impegni nazionali, Gustavo Spector si alza alle 5:45 del mattino. Sbriga il lavoro organizzativo, e poi è in campo, a volte alle otto del mattino, altre alle sette, perché nella capitale economica d’Italia c’è chi vuole giocare prima di andare in ufficio. Così dal lunedì al giovedì, «e la sera torno a casa distrutto: mi chiedo come diavolo faccia, la gente che ha figli, a non crollare! Io torno a casa e non ho la forza per fare assolutamente nulla». Nel fine settimana, c’è da seguire la nazionale che gira per il circuito Slam, e lì il CT allena e visiona i giocatori, oppure sale in automobile e va a tenere uno dei corsi di formazione.
Prendere la prima lezione di padel da Gus Spector è come scendere in campo col pallone per la prima volta e trovarsi Fabio Capello o Massimiliano Allegri che ti spiegano come mettere il piede, e ti fanno capire quanto è bello giocare. Chi ha il privilegio di poterlo fare, difficilmente si staccherà dal padel. Ma il suo sogno è che, di Gustavo, in Italia ne nascano sempre di più, e che l’Italia diventi la nuova Argentina: lui ne è sicuro e, dopo averlo visto all’opera, è difficile non credergli.